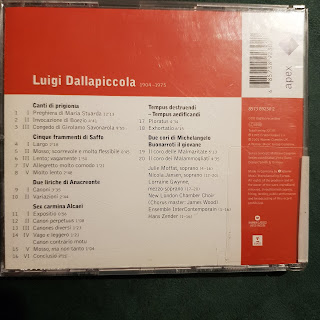La chiusa del secondo movimento della Fantastique
Dutuoit, Gergiev e Celibidache affondano le ultime note, rallentando. Maazel, Bernstein, Prêtre, Mitropoulos, Ormandy, Dudamel e Muti seguono la strada opposta, stringendo. Abbado sceglie una soluzione intermedia (prima accelera e rallenta sulle ultimissime note). Altrettanto Karajan (che, al contrario, prima rallenta e nelle ultimissime note accelera), Barenboim, Rattle e Mehta. Dudamel stringe molto, mantenendo però lunga la nota finale. Celibidache, Mitropoulos, Rattle e Bernstein fanno sentire molto bene tutte le note nei passaggi veloci dei violini. Mille e più mille scelte diverse per un finale di movimento che, comunque lo si prenda, è travolgente.