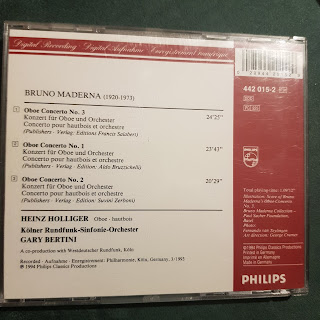In una rassegna come quella dei concerti per vari strumenti composti da Richard Strauss e incisi, per esempio, da Tuckwell, Belkin, Gulda e Ashkenazy, si nota tutta la vena fluentemente romantica dell'Autore, debitore di Schumann, Schubert e prima ancora della tradizione di Beethoven e Brahms e che interpreta, pur in veste di epigono, il grande genere romantico del concerto per strumento solista e orchestra con schietta fantasia e passionalità, in contrapposizione al mondo dolente e cupo del suo contemporaneo Mahler, spesso decadente nei toni. Differenza che notava, pur parteggiando per Gustav, la moglie Alma la quale peraltro non sempre mostrava di apprezzare le sottigliezze stilistiche del marito, come quando, per esempio, diede della composizione di tipo "haydniano" alla quarta sinfonia, che invece è un vero miracolo di rimpianto.