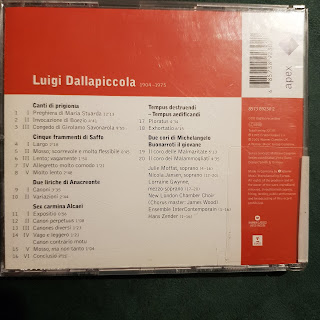Il terzo movimento della quarta sinfonia di Mahler diretto da Kubelik
Assistito da un'orchestra dai colori e dal virtuosismo unici come la Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks, Kubelik esprime qui il bizzarro e l'atroce in modo ancora più tipico di quanto riuscì a fare Bernstein con i Concertgebow, e collocandosi - nell'interpretazione di questo celebre movimento - più vicino a Boulez che ne mostrò l'ironia (mentre a Bernstein invece riuscì di immedesimarsi interamente nel dolore e nella passione che qui vengono espressi). Queste ed altre consimili riflessioni sulla quarta di Mahler , oltre che qui sul blog, anche in alcuni dei miei testi .